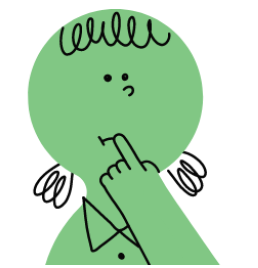Dea madre sarda spiegata ai bambini
Mitologia
Per folklore d'Italia si intende il folklore e le leggende metropolitane del nostro Paese. All'interno del territorio italiano si sono succeduti nel tempo diversi popoli, ognuno dei quali ha lasciato la propria impronta nella cultura attuale. Alcuni racconti derivano anche dalla cristianizzazione, soprattutto quelli riguardanti i demoni, che a volte sono riconosciuti dalla demonologia cristiana. Il folklore comprende anche la musica popolare, la danza popolare e gli eroi popolari.
Processo alle streghe in Val Camonica. Traduzione dell'iscrizione: "In memoria dei Federici di Sonico accusati di eresia e delle vittime dei roghi per stregoneria del XVI secolo in Val Camonica".
La danza popolare italiana è da secoli parte integrante della cultura italiana. La danza è stata un filo conduttore della vita italiana da Dante fino al Rinascimento, all'avvento della tarantella nel Sud Italia e ai moderni revival della musica e della danza popolare. Uno dei primi tentativi di raccogliere sistematicamente le danze popolari è l'opera di Gaspare Ungarelli del 1894 Le vecchie danze italiane ancora in uso nella provincia bolognese, che fornisce brevi descrizioni e musiche per circa 30 danze.[129]
Cartaginesi
Abbiamo scritto de Le 4 Leggende di "Ichnusa", dove l'origine dell'antico nome della Sardegna si riconduce sempre a un modello di sandalo. Abbiamo anche ipotizzato che sia la stessa impronta che la Sardegna lascia nei nostri cuori fin dalla prima visita, un'impronta che sa di resina, di salmastro e dell'anima stessa della sua gente di origine antica, un po' rude, ma in realtà gentile e appassionata.
Il culto della Dea Madre è confermato dalle numerose statuette che rivelano come in Sardegna si onorasse una divinità femminile. Avevano acconciature elaborate, seni importanti e fianchi larghi, indici di fertilità. Era una divinità che si riproduceva per partenogenesi, "nasceva da sola", senza intervento maschile. Il suo potere era ovunque, nelle pietre e nell'acqua, negli animali e nei fiori. I suoi seni cantavano la vita che stava dando. Risvegliava la terra dopo l'inverno per offrire i suoi prodotti agli uomini, alleviava la produttività degli animali. Era vita, morte e rinascita.
Successivamente, le figure della Dea Madre dell'Età del Rame saranno ritrovate su lastre di metallo, ma la figura divina maschile comincia già ad affiancare quella della Dea Madre (tra il 5.000 e il 4.000 a.C.). Nel corso del tempo la Dea Madre sarà sostituita da figure maschili che diventeranno figlia di un dio padre, moglie di un dio marito, sorella di un dio fratello, madre di un dio e figlio maschio. Poi, con la sovrapposizione culturale del cristianesimo al paganesimo, tutti i siti megalitici dedicati alla Dea Cunnusa furono gradualmente ribattezzati, letteralmente, dai sacerdoti della nuova Chiesa.
Simbolo di Tanit
Generalmente incarnazione della Terra, la Dea Madre nelle civiltà pagane è la creatrice dell'Universo, associata a molteplici aspetti della vita, dalla creazione e procreazione, alla natura e al lavoro della terra, alla famiglia e alla protezione dei bambini, ma anche alla cultura, al linguaggio e alla comunicazione.
La Venere di Willendorf è una statuetta che si stima sia stata scolpita tra i 28.000 e i 25.000 anni prima di Cristo. È stata scoperta nel sito archeologico paleolitico vicino a Willendorf, in Austria.
La stessa rappresentazione della Madre-Terra (spesso la troviamo citata come Gaia, in riferimento a una denominazione originaria della mitologia greca) associa la figura femminile alla fertilità, in varie mitologie, essendo addirittura la madre di tutte le altre divinità.
Analizzando brevemente uno dei pantheon più noti della Storia, quello greco, si percepisce facilmente che gli attributi della Dea Madre (fertilità, natura, salute, educazione) sono più o meno distribuiti dalle varie dee principali:
Dea Ashtoreth
Prima delle due mogli di Filippo V, re di Spagna, Maria Luisa Gabriella di Savoia nacque il 17 settembre 1688 nel Palazzo Reale di Torino, nel Ducato di Savoia, oggi in Italia. Era la terza dei sei figli e la terza delle tre figlie di Vittorio Amedeo II, re di Sardegna, e di Anna Maria d'Orléans. I nonni paterni di Maria Luisa erano Carlo Emanuele II, duca di Savoia, e la sua seconda moglie Maria Giovanna Battista di Nemours. I suoi nonni materni erano Filippo I, duca d'Orléans (figlio del re Luigi XIII di Francia e unico fratello del re Luigi XIV di Francia) e la principessa Henrietta d'Inghilterra (figlia del re Carlo I d'Inghilterra).
Poco dopo il suo arrivo in Spagna, il nonno di Filippo V, il re Luigi XIV, gli organizzò un matrimonio. Per rafforzare l'autorità vacillante di Filippo V sulla Spagna a causa della sua nascita francese, il re Luigi XIV decise di mantenere i legami con Vittorio Amadeo II, allora duca di Savoia, la cui figlia maggiore Maria Adelaide di Savoia era già sposata con il fratello maggiore di Filippo V, Luigi, duca di Borgogna, Le Petit Dauphin. Felipe V fu promesso in sposa alla tredicenne Maria Luisa di Savoia. A Torino, nel Ducato di Savoia, Felipe e Maria Luisa si sposarono per procura il 12 settembre 1701. Maria Luisa partì poi per la Spagna, dove la giovane coppia si incontrò per la prima volta il 2 novembre 1701 e si sposò personalmente nella chiesa parrocchiale di Figueres, in Spagna.